Promuovere una didattica inclusiva in classe è una sfida molto complessa perché ha come obiettivo quello di garantire il massimo grado di partecipazione da parte di tutti gli studenti, valorizzando ogni singolo alunno e, al contempo, ogni singolo insegnante con il proprio stile di insegnamento. Insegnare e apprendere sono da sempre “atti sociali”, sia che questo avvenga insieme ai docenti sia che lo si faccia insieme ai compagni di classe, che sono una grande risorsa, molto spesso trascurata e inutilizzata. Quindi, insegnare ai ragazzi significa innanzitutto socializzare, conoscersi, valorizzare ciò che può trasmettere la collaborazione e la cooperazione, sia a livello informale che a livello tecnico di tutoring. Con queste parole, i Professori Antonio Liguori e Domenico Divasto esordiscono nel loro project work sullo storytelling didattico al termine di una giornata formativa che ho condotto online con i docenti dell’Area di Corigliano Calabro, neo-immessi al ruolo per l’Anno Scolastico 2019-2020. Le interessanti considerazioni che offre il loro testo introducono, di fatto, la scuola del futuro, la scuola del docente creativo e dell’insegnamento personalizzato. Vi lascio alle loro parole.
L’adattamento
Un punto chiave di un percorso così delineato è quello dell’adattamento. Rispondere ai bisogni educativi speciali degli alunni presenti nelle nostre classi significa adattare
- i materiali,
- la programmazione,
- gli obiettivi e
- le modalità di lavoro
che il docente pone in essere all’interno delle classi. L’adattamento, pertanto, non riguarda solo il materiale didattico ma anche lo stile della lezione, l’essere carismatici, il saper coinvolgere gli alunni, suscitando in loro emozioni che ne accrescono l’interesse, così come succede quando gli obiettivi sono individualizzati o personalizzati.
Le strategie logico-visive
È in questo stesso ambito che troviamo le strategie logico-visive (mappe, schemi e aiuti visivi). Sappiamo bene come la scuola potenzi alcune competenze linguistiche, di
- analisi del testo,
- esposizione orale e
- di scrittura,
mentre, a volte, vengono sfruttate molto poco altre caratteristiche come quelle logiche e visive. Quindi, non solo mappe e schemi, che sono certamente tra gli strumenti più importanti, ma di fatto un’azione, una competenza che va sviluppata negli alunni per insegnare loro a esporre ed esprimere le proprie conoscenze, il proprio pensiero, attraverso lo sviluppo della logica. Una logica che porta a concretizzare il lavoro con strumenti prevalentemente visivi ed estremamente semplici come quelli
- di misurazione del tempo,
- le forme di schematizzazione,
- le mappe mentali e concettuali,
strumenti sicuramente molto importanti per tutti gli alunni proprio perché permettono al pensiero di svilupparsi attraverso azioni concrete e pratiche. La costruzione delle mappe, in particolare, si rivela un ottimo strumento di facilitazione e compensazione didattica per tutti quegli alunni DSA che presentano difficoltà nell’apprendimento.
Gli stili d’apprendimento
Altro punto chiave sono i processi cognitivi e gli stili di apprendimento. Sappiamo bene come l’efficacia didattica derivi dalla qualità
- degli strumenti,
- dei metodi di apprendimento e
- di insegnamento
e come i bambini imparino e sviluppino le loro competenze solo attraverso rigorosi e specifici passaggi evolutivi.
Riteniamo, perciò, che una delle osservazioni ed analisi più importanti che il docente possa mettere in atto sia quella di comprendere lo stile di apprendimento di ogni singolo alunno, capire come trasmettere e modellare il trasferimento di conoscenze che spesso non corrisponde allo stile d’apprendimento dei singoli studenti.
Dati, infatti, i tre macro stili di apprendimento,
- visivo per immagini, che prevede utilizzo di disegni o piccoli schemi con cui fare associazioni visive per creare dei “film mentali”,
- per suoni e parole, incentrato sul verbale, sul normale stile “leggi e ripeti” (insegnamento basato sul ripetere ad alta voce, lezione frontale, racconto ecc.),
- sensoriale e fisico: basato sull’esperienza, sui laboratori (schemi, mappe, video, gite, visite, creazione e costruzione fisica dell’apprendimento),
il miglior aggiornamento per l’insegnante del futuro non può che essere un percorso pratico che faciliti l’emersione dei talenti e degli stili di apprendimento per adattarvi l’insegnamento.
Emozioni e motivazione
Uno degli aspetti più importanti nella crescita degli alunni è la motivazione che si può definire come l’insieme di forze che portano ad alternare gli stati di tensione (comportamento) alle pulsioni, una sorta di comportamento strumentale posto in essere per raggiungere una meta, soddisfare il bisogno e ridurre il desiderio. Il bisogno, ad esempio il bisogno di cibo, acqua, affetto ecc., rimanda a una particolare tensione che nasce in un organismo in seguito alla rottura di un equilibrio e contribuisce al contempo alla ricostruzione dell’equilibrio stesso.
Anche l’interesse è una componente fondamentale della motivazione, perché crea la consapevolezza di tendere ad un obiettivo da raggiungere. Così, possiamo provare interesse per un film di cui abbiamo sentito parlare ma che non abbiamo ancora mai visto e che, pertanto, ci sentiamo motivati a vedere.
Le variabili psicologiche nell’apprendimento
A scuola le emozioni sono spesso oggetto di attività didattiche specifiche. In realtà, tuttavia, la parte fondamentale del lavoro sugli aspetti emotivi riguarda proprio la costruzione della capacità dell’alunno di conoscere e gestire le variabili psicologiche che influiscono sul suo apprendimento:
- autoefficacia,
- autostima,
- determinazione,
- motivazione e
- capacità di raggiungere un obiettivo.
Peraltro, per gli alunni più fragili, quelli che hanno bisogni educativi speciali, queste componenti strategiche sono addirittura fondamentali, proprio perché se non si lavora, attraverso specifici percorsi operativi, sulle caratteristiche psicologiche degli alunni, è impossibile che essi acquisiscano una certa sicurezza nei propri mezzi. In tutto questo è fondamentale l’autoconsapevolezza.
La conoscenza di sé, infatti, influisce non solo
- nel rapporto con gli altri, nell’aspetto relazionale (ciò a cui la scuola deve comunque preparare), ma anche
- nella pratica educativa e didattica e
- nella capacità di affrontare i singoli compiti e le prove di verifica, che oggi riguardano la scuola ma che, domani, serviranno per la vita stessa.
Le verifiche
A proposito di verifiche, occorrerebbe iniziare a pensare di adattarle all’eterogeneità e alla complessità delle classi con cui si lavora quotidianamente. Come afferma Ken Robinson ne “La scuola creativa”, alla valutazione va affiancata l’autovalutazione degli alunni, sia sul piano individuale che di gruppo. Autovalutarsi – recenti studi lo dimostrano – è la competenza strategica di maggiore successo all’interno dell’intero percorso educativo. Un bambino che sviluppa la capacità di autovalutare il proprio lavoro, infatti, è un bambino
- più sicuro di sé,
- capace di valutare i propri successi e
- di raggiungere dei risultati molto efficaci all’interno del proprio percorso di studi.
Certo, molto dipenderà dalla qualità del feedback. Meglio, allora,
- l’insegnante-coach, che incoraggia e fa il tifo per i propri ragazzi,
- pro-positivo,
- una guida che sa correggere e orientare il comportamento degli studenti.
Ma, esattamente come accade nel mondo dello sport, dove la prima qualità che è richiesta al tecnico della squadra è conoscere bene i propri giocatori, anche nella scuola, tra insegnante e studenti deve intercorrere la medesima distanza. O non è forse vero che anche i campioni hanno difficoltà ad ambientarsi, quando tutto ciò che accade intorno è spersonalizzante?
Perché a scuola dovrebbe essere diverso?
Ben vengano allora le storie in classe che fanno sentire protagonisti.












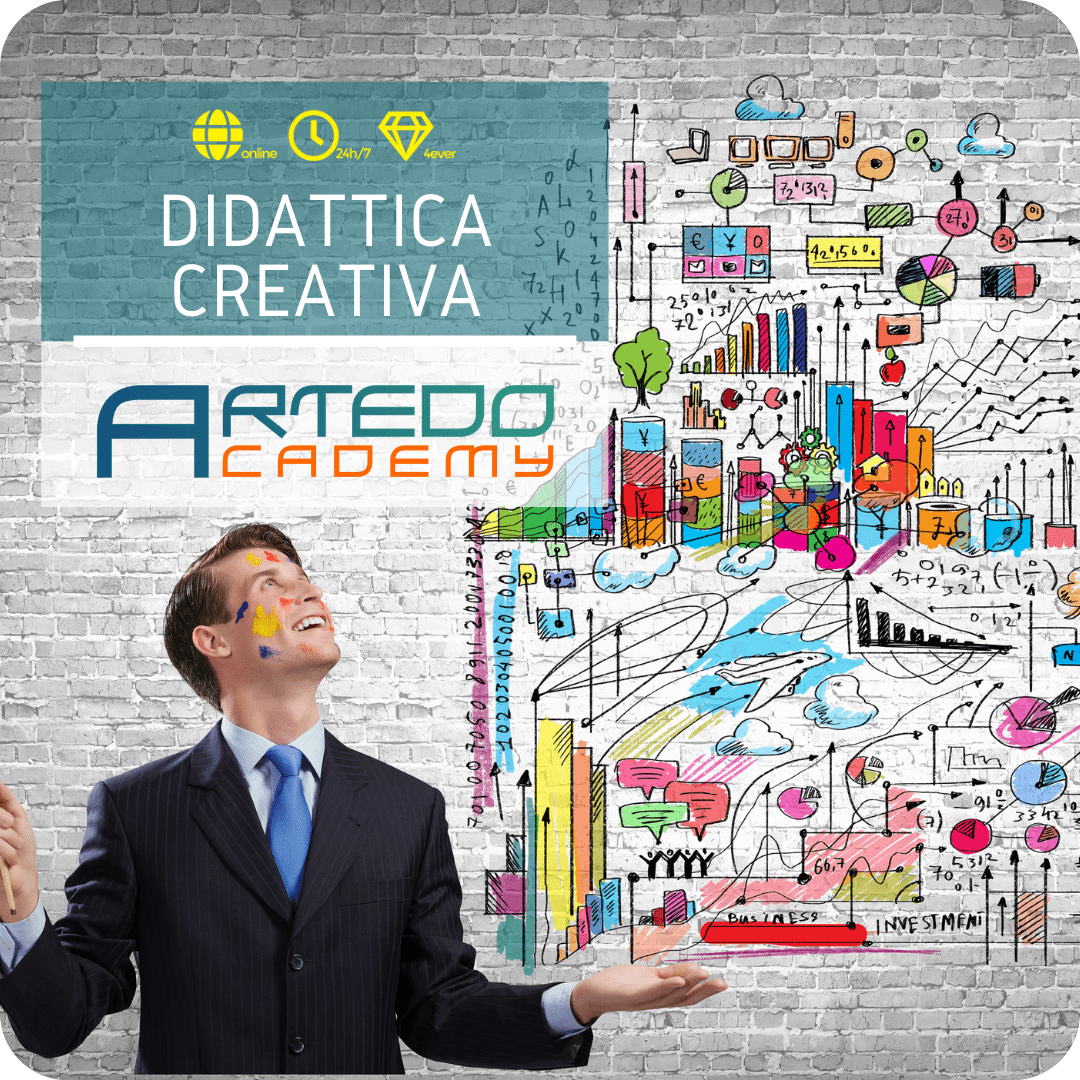












0 commenti